Afasia e trattamento
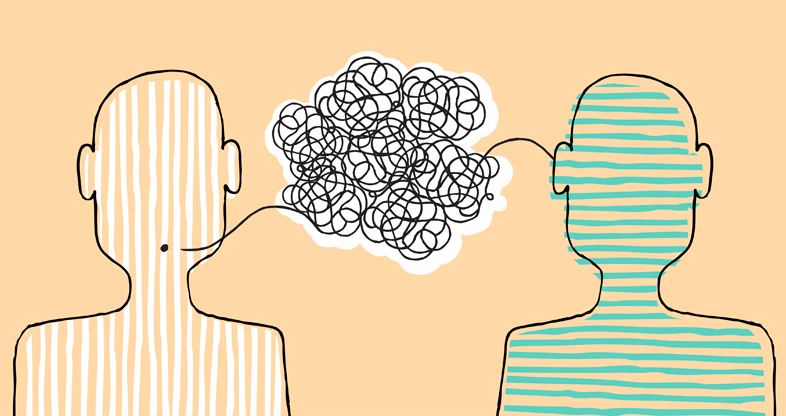
QUAL È IL PERIODO MIGLIORE PER INIZIARE IL TRATTAMENTO?
L’afasia non è un disturbo statico, bensì evolve nel tempo. Nei primi mesi successivi all’evento che ne ha causato la comparsa, si ha un recupero spontaneo: esso è maggiore nel primo mese, poi si riduce gradualmente nei 6-8 mesi successivi. In questo periodo è auspicabile una presa in carico logopedica e neuropsicologica al fine di potenziare al massimo le possibilità di recupero, prima che il quadro si stabilizzi nell’arco di circa un anno dall’evento neurologico.
Quali obiettivi ha il trattamento logopedico?
EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO LOGOPEDICO
Fino agli anni ’80 del ‘900, il focus riabilitativo era rivolto quasi esclusivamente al disturbo linguistico e, di conseguenza, si riteneva che il trattamento logopedico dovesse rimediare ai deficit di linguaggio (approccio classico). Venivano dunque proposti al paziente esercizi di difficoltà crescente per recuperare prima la comprensione e poi la produzione verbale. L’approccio classico, tuttavia, presentava alcuni limiti, tra cui l’aspecificità del trattamento (veniva considerata solo la gravità del disturbo e non le caratteristiche specifiche di ciascun soggetto) e l’assenza di reale scambio comunicativo e relazionale tra paziente e terapista.
Il modello appena descritto è stato poi sostituito da un approccio neurolinguistico: partendo da un’attenta valutazione di ogni sottocomponente del linguaggio, il trattamento veniva finalizzato alla rimediazione del disturbo specifico del paziente.
Successivamente, si è giunti ad un approccio cognitivista o ‘neurocognitivo’, secondo cui, è fondamentale comprendere, attraverso una diagnosi funzionale, quali moduli cognitivi (alla base delle abilità linguistiche) siano danneggiati e quali siano adeguate per poter capire da dove iniziare e come raggiungere l’obiettivo prefissato.
Tuttavia, la modalità di trattamento basata sul miglioramento delle singole sottocomponenti deficitarie, non è sufficiente, in quanto il linguaggio verbale non è l’unico mezzo di comunicazione che la persona può sperimentare. Inoltre, se utilizziamo questo approccio, i casi di disturbo afasico più severo la riabilitazione potrebbe essere considerata vana, dato che il disturbo linguistico della persona potrebbe non essere mai totalmente rimediato.
L’APPROCCIO RIABILITATIVO si è perciò gradualmente spostato a favore di una maggiore considerazione delle abilità comunicative, non solo verbali, che il paziente afasico può sperimentare anche dopo la lesione neurologica. Le competenze comunicative sono solitamente maggiormente preservate rispetto a quelle puramente linguistiche e possono essere sfruttate nel trattamento logopedico per permettere al paziente di comunicare con qualunque mezzo e su qualunque canale comunicativo. Si accompagna perciò il soggetto alla scoperta delle diverse possibilità di comunicazione, alternative alla verbalità, si oltrepassa il disturbo più o meno marcato a livello del linguaggio verbale che è il principale ostacolo agli scambi comunicativi (approccio pragmatico-conversazionale).
Il tipo di trattamento associato a quest’ultimo approccio, tuttavia, secondo alcuni autori risulterebbe limitante poiché vengono svolte attività di role-playing non sempre corrispondenti alle situazioni reali di vita quotidiana dei pazienti.
Un metodo “funzionale” deve tener conto delle caratteristiche dell’ENTOURAGE FAMILIARE DEL PAZIENTE, per rendere più olistico il trattamento logopedico della persona con afasia. Si è giunti così a ciò che si configura nell’approccio di tipo sociale. In questo caso, la presa in carico non è rivolta unicamente alla persona con afasia, bensì dovrebbe coinvolgere i diversi soggetti che vi ruotano intorno. Il partner comunicativo può, infatti, ricoprire il ruolo di facilitatore oppure, al contrario, essere di ostacolo alla comunicazione, costituendo, in quest’ultimo caso, una sorta di “barriera comunicativa” nei confronti della persona con afasia. Tra persona con afasia e partner comunicativo deve essere presente una “collaborazione conversazionale”, pertanto è necessario che siano presenti buone abilità conversazionali da parte sia della persona con afasia sia dell’interlocutore, ragione per cui è necessario un TRAINING SPECIFICO rivolto ad entrambi, che porti a sperimentare e incrementare le competenze comunicative in tutti i contesti potenzialmente comunicativi. La riabilitazione logopedica dell’afasia, in questo modo, oltre al miglioramento comunicativo-linguistico, tenta di migliorare la qualità di vita, eliminando ciò che costituisce una barriera alla possibilità di inclusione e partecipazione sociale della persona con afasia. L’intervento si focalizza quindi non solo sui fattori individuali, ma anche sui fattori ambientali: i caregiver (ovvero le persone significative che ruotano intorno alla persona) vengono dunque preparati a ricoprire il ruolo di facilitatori e a rendere aphasia-friendly l’ambiente in cui è inserito il soggetto, contribuendo al miglioramento degli esiti e della qualità di vita.
Quali obiettivi ha il trattamento neuropsicologico?
UN PO’ DI STORIA
La realtà clinica riabilitativa neuropsicologica è stata molto eterogenea sin dai primi decenni del ‘900. Alcune tecniche miravano maggiormente a ‘ricostruire’ un vocabolario di base con il paziente utilizzando le parole di uso più frequente e facendole ripetere più volte alla persona (Kussmaul, 1987 – Miceli, 1996). Alcuni psicologi cognitivi (Mitchum e Berndt, 1991) proponevano invece, per la rieducazione delle ‘vie’ di conversione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, vari esercizi di ripetizione dei suoni (lettere, sillabe e parole) e messa per iscritto degli stessi, con continui esercizi.
Oggi il focus del trattamento è diventato maggiormente specifico e dettagliato per ciascuna persona: proprio perché si è visto come è possibile rendere ESPLICITO il nesso logico tra il DANNO NEUROLOGICO e l’ESITO comunicativo-linguistico, ‘tarando’ perciò un intervento maggiormente ad-hoc.
QUINDI? VARIE TIPOLOGIE DI DANNO NEUROLOGICO = VARIE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO!
In ogni persona che ha avuto un ictus con esito afasico (di vario tipo e grado) i problemi possono essere dei più svariati: un problema alle vie di trasmissione tra lo scritto ed il parlato (conversione grafema-fonema), un danno ad un buffer (rete neuronale che permette la trasmissione tra i segnali lessicali, semantici e fonologici), un danno specifico di una o più componenti del linguaggio etc…
LA NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA
Gli psicologi cognitivi studiano l’ARCHITETTURA DELLE FUNZIONI dei PROCESSI COGNITIVI (come si costruisce il significato della parola? come la si associa a quell’oggetto? come si usa e come si forma nel contesto di apprendimento della persona?).
“Se non so a cosa è dovuto un determinato comportamento patologico, sarà difficile anche individuare un trattamento adeguato e completo; se ne conosco la causa, al contrario, saranno razionalmente giustificati solo i trattamenti coerenti con la causa sottostante al comportamento patologico” (Howard & Hatfield, 1987)
Il trattamento neuropsicologico cognitivo si basa su 3 principi fondamentali:
MODULARITA’: una funzione del nostro cervello deriva dal funzionamento di varie sotto-componenti del sistema cerebrale, che possono essere coinvolte a volte anche singolarmente da un danno come un ictus.
UNIVERSALITA’: tra varie persone vi sono differenze soggettive nell’utilizzo del linguaggio personale e quotidiano e nella comunicazione, tuttavia ci sono delle ‘strutture cognitive’ neuronali che accomunano gli individui tra loro, nelle varie sottocomponenti linguistiche-comunicative.
TRASPARENZA: quando una o più funzioni del linguaggio vengono compromesse, le altre continuano a funzionare in maniera normale, tenendo conto che possono però emergere dei problemi anche nelle funzioni non compromesse a causa magari di un ‘input’ del messaggio (comprensione, ad esempio) che può essere difficoltoso.
Il neuropsicologo si propone di indagare le FUNZIONI che vengono COINVOLTE nel disturbo afasico, facendo un’attenta analisi funzionale e non solo descrittiva, tenendo conto delle varie capacità compromesse nella problematica afasica di linguaggio e di comunicazione: problemi di attenzione, memoria di lavoro, controllo inibitorio, funzioni esecutive, esiti comportamentali.
Un’adeguata analisi incrociata dei risultati di neuroimaging (esami neurologici), assieme ad un’analisi clinica quantitativa e qualitativa della parte di testistica neuropsicologica cognitiva, può fornire dati molto più dettagliati relativi alla problematica presente nella persona.
Esempio pratico: se una persona ha subito un ictus che, proprio per la sua natura ematica, ha avuto effetti pervasivi in aree del cervello adiacenti alle aree ed ai circuiti neurologici del linguaggio, l’attenzione del neuropsicologo andrà a posarsi anche su quelle aree del cervello secondariamente coinvolte nell’evento neurologico. Se la pervasività dell’evento, ad esempio, ha colpito in maniera consistente anche i lobi frontali, il neuropsicologo pone un’attenzione maggiore anche nell’esaminare se vi siano delle incidenze comportamentali o sull’inibizione della risposta allo stimolo (componenti derivate dalla funzionalità dei lobi frontali) che debbano essere magari trattate e che, se non venissero prese in carico, rallenterebbero o influenzerebbero il buon esito della parte di trattamento mirata al linguaggio ed alla comunicazione.
Una diagnosi cognitiva completa, unita a quella cognitiva sul linguaggio e la comunicazione, è indispensabile come punto di partenza e più è precisa una diagnosi, tanto più chiari saranno il punto di partenza e gli obiettivi della riabilitazione. (Basso, 2005)
Una buona collaborazione, perciò, tra professionisti psicologi-neuropsicologi e logopedisti è di fondamentale importanza per la buona riuscita del trattamento e per una massima resa.
Per informazioni maggiormente dettagliate sulla riabilitazione: Consensus Conference Nazionale “La Riabilitazione Neuropsicologica nella persona adulta. Riabilitazione dei disturbi del linguaggio e del calcolo: Afasie, Alessie, Agrafie, Acalculia”, Siena, 2010.
Siti utili: http://www.aitafederazione.it/aita/
Consiglio di lettura: “Ogni parola che sapevo”, Andrea Vianello, 2020.

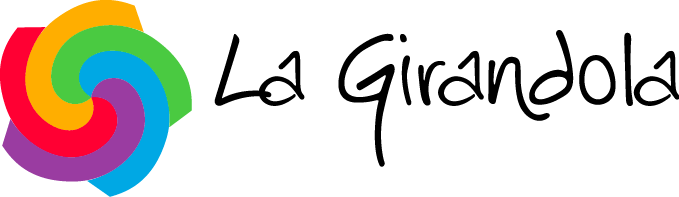


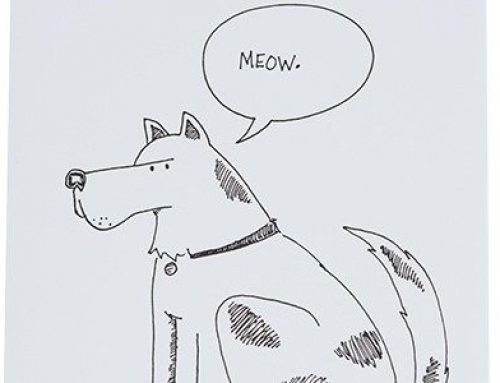
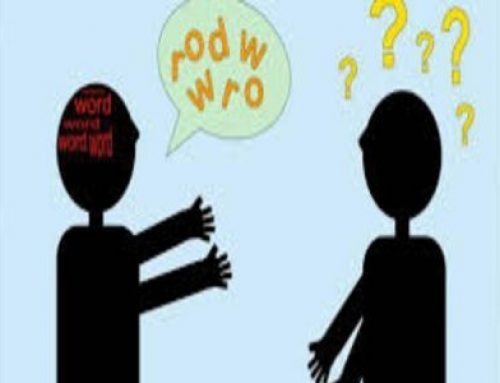
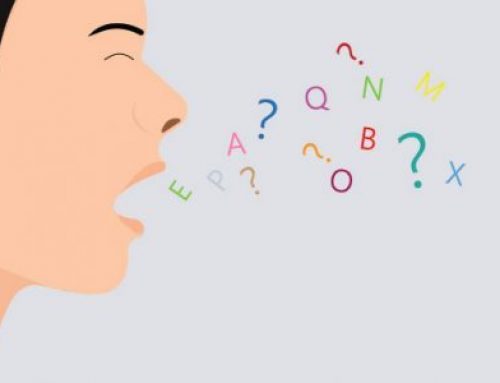
Scrivi un commento