IL RITIRO SOCIALE IN ADOLESCENZA
“Quando sono soli vogliono stare con gli altri,
e quando sono con gli altri vogliono stare soli.
Dopo tutto gli esseri umani sono così.”
Gertrude Stein

La manifestazione del ritiro sociale (social withdrawal) a partire dall’infanzia fino all’età adulta è un fenomeno che, negli ultimi anni, sta assumendo forme e dimensioni sempre più preoccupanti. Infatti, se alcuni individui, adulti o bambini, appaiono felici di spendere una larga parte del loro tempo lontani dagli altri senza che questo costituisca una forma di disagio, il ritirarsi dalle relazioni può costituire un segno di difficoltà sociali o emotive nascoste.
Sindrome Hikikomori
Il ritiro messo in atto dai ragazzi di cui vogliamo parlare, tende ad assumere forme serrate di isolamento, conosciuto anche come Sindrome Hikikomori, fenomeno identificato originariamente in Giappone e ritenuto inizialmente una condizione specifica della società nipponica. Solo in seguitone è stata riscontrata l’esistenza anche in paesi e culture differenti, a dimostrazione che si tratta di un fenomeno trasversale a culture e società diverse.
Il termine “Hikikomori” è stato coniato da Saito Tamaki, un noto psichiatra giapponese, agli inizi degli anni ’80, per definire un fenomeno che si esprime attraverso il “ritiro sociale”, una volontaria reclusione dal mondo esterno, una forma di auto-esclusione, isolamento dal contesto sociale e rifiuto totale per ogni forma di relazione. La parola hikikomori è composta da due parti, “Hiki” che significa “ritiro” e “Komori” che vuol dire “essere rinchiuso”.
Gli hikikomori sono adolescenti che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), e di rinchiudersi nella propria abitazione, senza avere nessun tipo di contatto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori e familiari: nelle forme più gravi trascorrono il tempo nella propria stanza, arrivando a coprire le finestre con fogli di carta scuri e nastro adesivo perché neanche la luce del sole li raggiunga, e i genitori lasciano loro i pasti fuori dalla stanza.
Lo psichiatra Saito Tamaki nel riferirsi al fenomeno degli hikikomori non parla di malattia, ma di disagio adattivo sociale che riguarda tutti i paesi economicamente sviluppati del mondo.
Secondo una classifica della diffusione del fenomeno nel mondo, l’Italia si collocherebbe al 4^ posto, preceduta da Giappone (1° posto), Corea (2°) e Spagna(3°). In Italia le cifre ufficiali ipotizzano un numero di ragazzi “ritirati sociali” che si aggira intorno ai 120 mila, con una prevalenza maggiore tra i maschi, anche se il numero delle femmine è in aumento.
Gli interventi migliori e più efficaci sono quelli precoci, messi in atto fin dalle prime manifestazioni di segnali di disagio nei ragazzi; se in Giappone la diagnosi di Hikikomori viene posta quando un ragazzo non esce di casa per un periodo di 6 mesi, un intervento precoce deve essere messo in atto molto prima che sia trascorso questo periodo di tempo.
Qual è la condizione clinica di questi ragazzi?
Parlando di “Ritiro sociale” facciamo riferimento a un quadro sintomatologico più che a una vera e propria malattia.
Nelle storie di sviluppo di questi ragazzi è frequente ritrovare un disturbo di ansia da separazione.
Rinchiudendosi nelle loro stanze e rifiutando ogni contatto con il mondo esterno, sono ragazzi che “si negano il futuro come se non lo meritassero” si ritrovano all’interno di un “universo chiusi da fili spinati”, dove diventa ormai difficile capire chi li ha messi questi fili, se loro stessi o altri (Elena Raino, NPI OIRM di Torino).
Al momento è in corso anche un dibattito sull’effettiva esistenza di un “hikikomori” primario: secondo alcuni esperti il ritiro sociale sarebbe sempre conseguenza della presenza di disturbo psichiatrico, mentre per altri questa non è una condizione necessaria. Una terza posizione ritiene che il ritiro stesso di tipo hikikomori possa essere considerato un disturbo psichiatrico.
I segni
Segni che possono caratterizzare una condizione di hikikomori sono: progressivo e persistente ritiro sociale, fobia scolare e abbandono scolastico, comportamento regressivo, apatia, inversione del ritmo circadiano di sonno– veglia, disinteresse verso il mondo e assenza del desiderio di stabilire relazioni interpersonali significative. Tuttavia la condizione di fragilità emotiva di questi adolescenti è palpabile e richiede una grande cautela da parte dei clinici nei primi incontri per stabilire una solida relazione terapeutica.
Dato che l’attenzione degli adulti di riferimento (genitori, familiari ed insegnanti) tende a concentrarsi soprattutto sulle assenza da scuola, diventa importante distinguere tra adolescenti che abbandonano la scuola per altre forme di disagio, e adolescenti con ritiro sociale. Inoltre, questo da solo può non essere un indicatore significativo: ragazzi e ragazze “sulla via del ritiro” possono continuare a frequentare regolarmente la scuola pur avendo di fatto interrotto tutti i contatti con i pari. Prestare attenzione a tutti i segnali di disagio, diventa quindi fondamentale per poter intervenire in modo precoce ed efficace, prima che il disagio si cristallizzi e renda il percorso di cura più lungo e difficile.
Quali sono i motivi del ritiro sociale?
Secondo lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini (Fondazione Minotauro) i motivi del ritiro sociale in adolescenza sono da ricondurre all’incapacità di affrontare le difficoltà imposte dal periodo di incertezze che si sta fisiologicamente attraversando. Questo spinge i ragazzi a sentirsi inadeguati, incapaci di vivere all’altezza delle aspettative dei genitori e della società.
Forti responsabilità sono da ricercare anche nel modello sociale con cui si confrontano i giovani, fondato sull’imposizione di essere vincenti e popolari a tutti i costi.
Anche la famiglia gioca un ruolo importante nel ritiro sociale in adolescenza. Secondo lo psichiatra e psicoterapeuta Gustavo Pietropolli Charmet, rispetto al passato, è emerso un nuovo modo di guardare al bambino: i genitori considerano il figlio naturalmente vincente, socievole, incline al rapporto con gli altri, e quindi bisognoso di poche regole. Di conseguenza la pressione educativa è notevolmente allentata, ma le aspettative sono aumentate e questo porterebbe a un maggior rischio per i ragazzi di sperimentare un senso di vergogna. Vergogna di cosa? Del corpo, percepito come goffo, brutto, non all’altezza del modello vincente, incapace di realizzare le aspettative di successo trasmesse fin dall’infanzia; vergogna per la propria “incapacità” nelle relazioni con i pari: gli altri sono percepiti come più competenti, brillanti, spiritosi, estroversi…
Come rimediare alla vergogna? Facendo sparire il corpo, e se stessi, dalla vista degli altri, chiudendosi in una stanza, quasi a punirsi per non essere stati capaci di tener fede alle promesse iniziali.
La vergogna sperimentata nelle diverse situazioni sociali da questi ragazzi, non è però l’unica spiegazione né l’unica emozione coinvolta.
I ragazzi che arrivano a manifestare ritiro sociale sono ragazzi spesso intelligenti, ma anche particolarmente sensibili e inibiti socialmente. Questo temperamento contribuisce alla loro difficoltà nell’instaurare relazioni soddisfacenti e durature, così come nell’affrontare con efficacia le inevitabili difficoltà e delusioni che la vita riserva.
L’ambiente scolastico viene vissuto in modo particolarmente negativo, sia rispetto alla pressione delle richieste di risultati performanti da parte di docenti e famiglia, sia nella relazione con i compagni, spesso visti come falsi e non affidabili. Spesso, dietro l’isolamento, possiamo trovare storie di bullismo che perdurano da tempo.
Le famiglie di questi adolescenti presentano alcune caratteristiche ricorrenti: il padre è spesso assente, soprattutto a livello emotivo, e i ragazzi sviluppano con la madre un legame molto forte: anche per questo motivo lei diviene poi il principale bersaglio della loro rabbia nei momenti di crisi o quando, allarmati dal dall’isolamento del figlio, i genitori provano a intervenire.
Al momento non si è ancora riusciti a fare chiarezza, su quali siano i fattori prevalenti e di maggior peso, e resta comunque un aspetto difficile. Certamente la società negli ultimi anni è cambiata e in modo estremamente rapido: nel mondo contemporaneo la fragilità dei ragazzi è maggiore, e si trovano allo tempo a muoversi entro reti sociali più deboli.
In alcuni di questi adolescenti c’è l’idea di non essere equipaggiati per la vita e per le relazioni.
Internet e ritiro sociale
La tanto discussa dipendenza da internet, spesso indicata come una delle principali cause dietro all’esplosione del fenomeno, rappresenta più una conseguenza del fenomeno: nei casi più gravi i ragazzi evitano ormai anche questo tipo di contatto con il mondo esterno.
Quando si osserva un progressivo ritiro “nella rete” da parte di ragazzi adolescenti, questo va letto come il segnale della presenza di un disagio e un primo, autonomo, tentativo di risolverlo. Internet può apparire loro come l’unica possibilità di accesso al sapere (ricerca di informazioni), di simbolizzazione (avatar, giochi di ruolo) e di relazione con gli altri (contatto corporeo mediato). Inoltre, l’accesso all’ambiente virtuale consente di anestetizzare vissuti di tristezza e solitudine, tenere a una distanza tollerabile le relazioni con gli altri, le angosce e il senso di inadeguatezza che ne deriva.
Nel lavoro terapeutico con questi ragazzi e le loro famiglie, la rete può essere il canale iniziale attraverso cui stabilire un contatto inziale con il ragazzo, in quanto se per lui/lei è difficile uscire di casa o lasciare la propria stanza, l’utilizzo di piattaforme di comunicazione online, e persino di avatar permettono di aggirare alcuni ostacoli.
Lo specialista deve mostrare interesse e attenzione alla “vita virtuale” di questi ragazzi, immergendosi empaticamente e con curiosità nelle opzioni virtuali individuate dall’adolescente ritirato socialmente.
Trovare risposte alla domanda “cosa fa l’adolescente su internet?” è fondamentale. Tramite gli ambienti virtuali che frequenta, la scelta di uno specifico argomento, videogioco e avatar l’adolescente ci sta parlando di sé. Il livello di compromissione va valutato non in funzione del tempo trascorso in rete, ma delle modalità di utilizzo: la situazione di un ragazzo che attraverso giochi on line e giochi di ruolo mantiene relazioni sociali, anche se virtuali, è ben divere da quella in cui la rete viene usata ormai solo più in modo passivo (es. visione compulsiva di video o serie televisive).
È importante, infine, prestare attenzione anche a quanto le scelte fatte nell’uso della rete siano o meno in linea con l’età di sviluppo del ragazzo, in modo da rilevare la presenza anche a questo livello di regressioni (scelta di giochi e/o avatar eccessivamente infantili rispetto all’età cronologica) o spinte in avanti non adeguate.
L’importanza della prevenzione
Quando il ritiro sociale si è radicato, riuscire a riportare i ragazzi alla vita sociale è molto complesso e spesso richiede interventi lunghi, intensi, potrebbero durare potenzialmente anche anni (da 3 a 4 ).
È quindi fondamentale intervenire fin da quando si manifestano i primi campanelli d’allarme, come assenze scolastiche non motivate, progressivo abbandono di attività parallele alla scuola o di tipo sportivo, una diminuzione del tempo trascorso con gli amici, la tendenza a invertire il ritmo sonno-veglia. In questa fase i genitori devono cercare di aumentare i momenti di comunicazione con il figlio, provando a indagare a fondo quali siano le motivazioni intime che provocano i comportamenti di isolamento.
Nel momento in cui si ha la percezione che tali comportamenti siano in fase di peggioramento è importante che i familiari cerchino immediatamente il supporto di un professionista esterno, senza aspettare che l’isolamento si concretizzi.
Intervento nel ritiro sociale
Il lavoro con gli adolescenti ritirati socialmente richiede un approccio multifocale che coinvolge numerosi operatori: parallelamente alla psicoterapia e all’attività di parent training con i genitori, vanno previsti interventi domiciliari o avvalendosi delle tecnologie informatiche, qualora l’adolescente non sia disponibile ad uscire di casa ma sia d’accordo di parlare con uno psicologo, attività laboratoriali individuali e di piccolo gruppo con lo scopo di facilitare l’accesso a relazioni interpersonali reali, esercitazioni che facilitino il reinserimento scolastico e sociale. Occorre anche effettuare, attraverso strumenti diagnostici appropriati, un’attenta valutazione del grado di dipendenza da Internet.
Rispetto al computer: sono sconsigliati interventi bruschi finalizzati a interrompere la relazione di super investimento nei confronti del PC e della realtà virtuale. Si suggerisce un atteggiamento di mediazione e di patteggiamento costante nei confronti di orari e regole domestiche.
La “Ri-scolarizzazione” è uno degli obiettivi fondamentali dell’intervento, soprattutto nella direzione del conseguimento di un diploma di scuola superiore: la maturità scolastica sancisce convenzionalmente l’ingresso nella vita adulta, e il riuscire a ottenere un titolo di studi permette di riconoscersi un ruolo sociale che, soprattutto per i ragazzi ritirati socialmente, costituisce un importante organizzatore psichico, un punto da cui costruire la propria identità all’interno della società.
Quando la strada del ritorno sui banchi di scuola non è impraticabile, l’acquisizione di un ruolo lavorativo può essere l’unica strategia per favorire il processo di risocializzazione. La funzione lavorativa offre indubbi vantaggi all’ex-ritirato: sostiene l’autostima e mitiga i sentimenti di inadeguatezza di fronte allo sguardo dell’altro.
La “Ri-socializzazione” è certamente l’obiettivo più importante di tutti, e ogni intervento non può che essere finalizzato a questo scopo. Proposte concrete di risocializzazione possono essere fatte solo a tempo debito, in coincidenza con i movimenti di sperimentazione e riapertura che emergono autonomamente. È pertanto fondamentale rispettare e non forzare, avvicinandosi in modo progressivo all’adolescente e comunicando il messaggio che “non faremo azioni che siano per te troppo rischiose”.
Il terapeuta deve tenere sempre a mente che le reali esperienze trasformative avvengono nella realtà e, quindi, occorrerà trovare modi e tempi per accompagnare e sostenere i ragazzi nel farle.

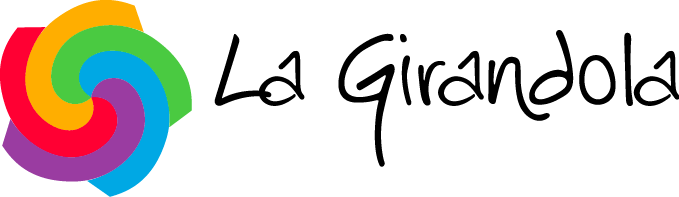


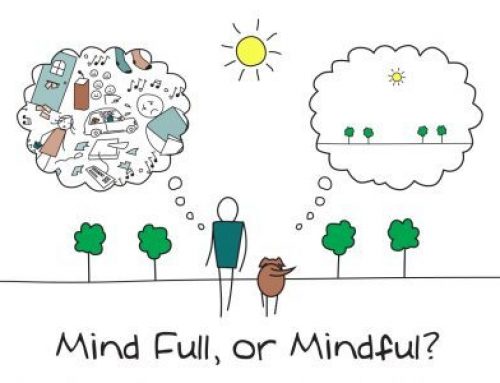


Buongiorno,
ho letto con Interesse il tema dei Hikikomori. Ma quali studi ci sono dal 2020 , situazione aggravato o modificata dal lockdown ed emergenza covid?